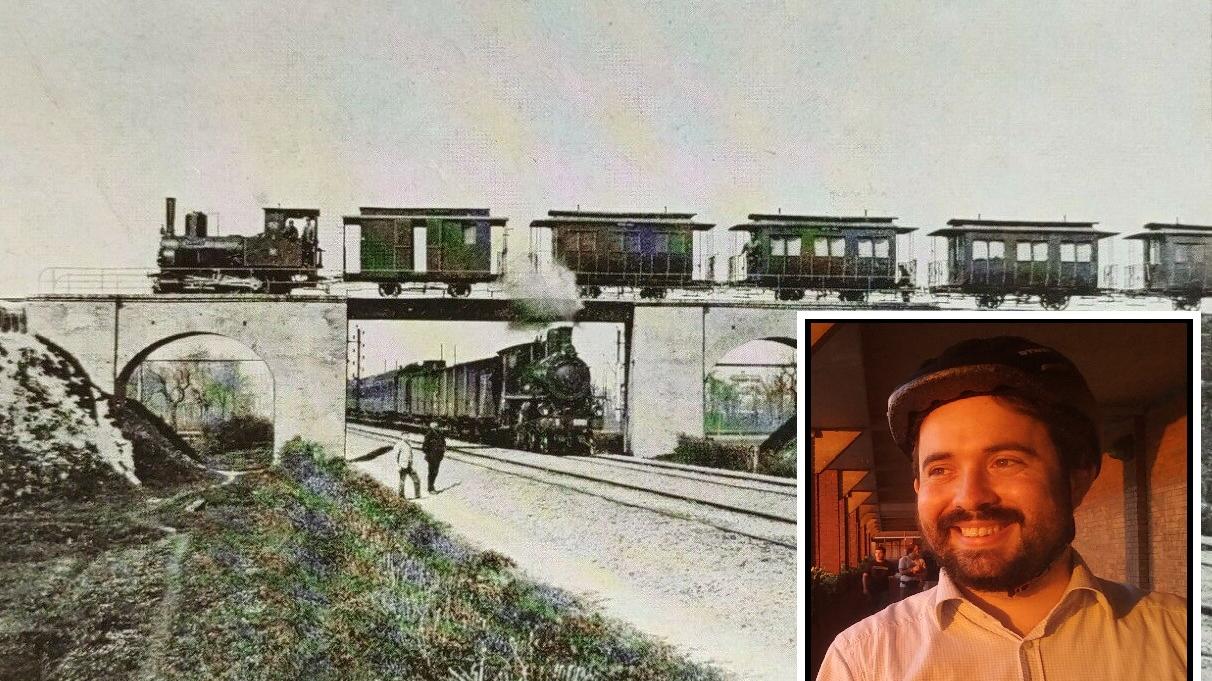Quelle ferrovie dimenticate che oggi sarebbero oro per una mobilità sostenibile
L’ingegnere trasportista modenese Claudio Borsari, che vive e lavora a Londra: «Toglierebbero dalle strade della provincia fino a 21mila auto. Impossibile recuperarle, ma si può intervenire sul capoluogo, su Carpi e sulla tratta per la Bassa»
MODENA. Il traffico sempre più congestionato delle strade e il conseguente impatto ambientale, economico e sociale che ha sulle nostre vite, spinge ad aprire una riflessione urgente e necessaria su quei collegamenti ferroviari tra Modena e provincia (e non solo) che oggi – se esistessero ancora – semplificherebbero la quotidianità dei pensolari. Tra queste, si ricordano ad esempio la Modena-Vignola, lungo un corridoio da tempo in sofferenza; la tramvia Modena-Maranello lungo la nuova Estense, e il mai completato collegamento per Pavullo; la ferrovia mai completata tra Mirandola e Rolo, con il possibile prolungamento a Novellara (la Cispadana non è un’idea nuova). E la linea Carpi-Bagnolo-Reggio, che potrebbe collegare Carpi con la stazione Mediopadana.
L’ingegnere trasportista modenese Claudio Borsari, che vive e lavora a Londra, esperto in pianificazione dei trasporti, premette: «Considerando che in media un auto è utilizzata da 1,17 persone, e livelli di utilizzo per linea tra 8mila e 25mila passeggeri/giorno (simili alla rete extraurbana di Karlsruhe in Germania), si possono togliere tra le 7mila e le 21mila auto al giorno dalla strada, di cui tra le 800 e le 2.500 in ora di punta».
Borsari, sul territorio modenese, quali sono gli errori più gravi commessi in passato nella gestione delle linee ferroviarie, che hanno portato all’attuale situazione di perenne traffico congestionato, inquinamento ecc.?
«Ovviamente la chiusura della maggior parte delle linee locali. Una scelta non solo di Modena, che va contestualizzata nel periodo in cui è stata realizzata (i servizi automobilistici sembravano offrire capacità sufficiente, più flessibilità, costi minori e frequenze maggiori), ma di cui quotidianamente vediamo i limiti. Una volta eliminata la priorità e la sede propria al trasporto collettivo, il servizio offerto non è più risultato competitivo, cosa che ha avviato una spirale di bassa domanda e disinvestimento. Allo stesso tempo, gli errori urbanistici di uno sviluppo del territorio disordinato e disperso, senza relazione con infrastrutture di trasporto efficienti, ha creato nuovo traffico verso poli servibili solo con il mezzo privato».
Le vecchie linee o sono state ricoperte dalle piste ciclabili oppure sono semplicemente non utilizzate: è verosimile e sostenibile pensare di ripristinarle in un qualche modo?
«Non sugli stessi percorsi ormai scomparsi e in parte inglobati nello sviluppo urbanistico, e comunque i lavori sarebbero probabilmente gli stessi necessari per costruire un nuovo tracciato. La Modena-Mirandola, ad esempio, ha sempre avuto problemi strutturali di cedimento del terreno, e trasportistici, con le stazioni lontane dai centri abitati. È però verosimile ripristinare un sistema portante di trasporto pubblico di area vasta lungo quelle stesse direttrici. Le aree di sofferenza restano quelle: Modena-Vignola, Modena-Mirandola/San Felice/Finale, Modena-Nonantola/Crevalcore/San Giovanni in Persiceto (la tratta iniziale della Modena-Ferrara), la pedemontana Vignola-Maranello/Formigine-Sassuolo; una linea Mirandola-Carpi-Mediopadana potrebbe migliorare e l’accessibilità del distretto biomedicale».
Che effetto avrebbe in termini economici, ambientali, sociali?
«I benefici – e gli impatti dell’assenza di interventi – sono noti: un territorio perennemente congestionato rischia di perdere attrattività economica, investimenti e forza lavoro, specialmente quella qualificata che ha possibilità di scelta. Inquinamento, sedentarietà, stress da traffico e collisioni hanno significativi impatti sociali e sulla salute ed è necessario fare un salto di qualità nella narrazione, evidenziando gli aspetti infrastrutturali e culturali che rendono le collisioni molto più gravi. L’impatto della crisi climatica, poi, rimane di tragica attualità».
Il beneficio economico è anche più immediato: rinunciare a un’auto permette un risparmio tra i 300 e 600 euro al mese…
«Che per alcuni possono fare la differenza tra arrivare o meno alla fine del mese, rendendoli immediatamente spendibili sul territorio, in attività commerciali o culturali che generano posti di lavoro locali. Migliorare l’accessibilità contrasta l’isolamento sociale, e apre alle opportunità economiche, sociali, educative e culturali del territorio, soprattutto per i più vulnerabili, che un’auto non possono permettersela o non possono guidarla».
Tecnicamente, cosa si potrebbe fare?
«Per prima cosa, strategicamente, sfruttare l’occasione offerta dal nuovo Prit che la Regione dovrà sviluppare nel 2025 per mettere a sistema lo studio di aMo sulla città di Modena e la Modena-Sassuolo e lo studio fatto dell’Area Nord sul corridoio Modena-Mirandola».
Il limite di quegli studi, basati sulla modellistica, è che non possono, per loro stessa natura, tenere conto dei cambiamenti delle condizioni al contorno: come muoversi?
«Mettere da parte la modellistica e la discussione su specifiche infrastrutture e tecnologie, e sviluppare un piano per agire sulle barriere all’utilizzo della mobilità sostenibile, non solo la scarsa frequenza dei mezzi (dovuta alla scarsità dei finanziamenti, i più bassi, pro-capite, della Regione, una stortura da correggere con estrema urgenza), ma anche interventi puntuali (ed economici, fattibili in tempi brevi) come l’accessibilità e la qualità delle fermate, la mobilità di ultimo miglio e la rete complementare alle direttrici principali. Servono poi strumenti urbanistici coerenti, che concentrino gli attrattori di domanda intorno a fermate e interscambi, creando un circolo virtuoso per cui rigenerazione e sviluppo urbano si fanno intorno alle infrastrutture, e le infrastrutture si fanno dove possono stimolare rigenerazione e sviluppo sostenibile».
© RIPRODUZIONE RISERVATA